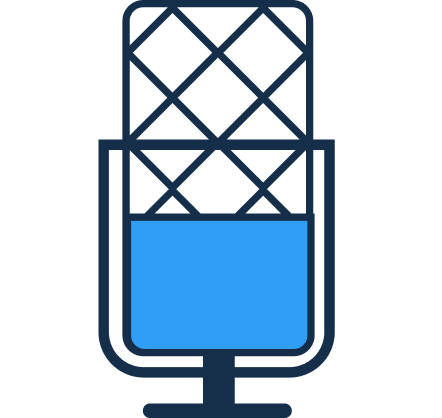Come ogni anno, la comunità di Romagnano ha celebrato la festa in onore del suo santo patrono, il martire Silvano. Questa volta, la ricorrenza ha assunto una particolare solennità, a motivo del trasporto giubilare dell’urna contenente le reliquie del santo che è stata portata in processione per le vie dell’antico borgo dopo la messa celebrata dal monsignor Adriano Ciocca Vasino, vescovo di origini valsesiane missionario in Brasile.
La figura di San Silvano e la storia della presenza nel paese alle porte della Valsesia di parte dei suoi resti mortali meritano un approfondimento che possa permettere di conoscerne i particolari, per conservare memoria dell’importante patrimonio di fede che i nostri antenati ci hanno trasmesso.
Da sempre la tradizione identifica il Santo venerato a Romagnano come uno dei sette figli di Santa Felicita, le cui vicende sono conosciute attraverso diverse fonti documentarie: una passio oggetto di numerosi studi, che hanno cercato di determinarne la storicità, le indicazioni di vari martirologi e due omelie, una del vescovo Pietro Crisologo, del 450 circa e un altra di papa Gregorio Magno.
Il racconto, tessuto sulla trama di quello biblico dell’uccisione dei sette fratelli Maccabei e della loro madre, è stato in passato respinto come leggendario. La tesi sembrava avvalorata dal fatto che, in diverse fonti antiche, i nomi dei santi protagonisti del racconto non figuravano legati tra loro. La più antica fonte che tramanda la memoria di questo gruppo di martiri – ossia la “Depositio Martirum” – tace sull’eventuale parentela dei santi riportati alla data del 10 luglio.
Anche i luoghi delle loro sepolture risultano differenti. Felicita e Silvano sono indicati come deposti nel cimitero di Massimo; Felice e Filippo nella catacomba di Priscilla; Vitale, Marziale e Alessandro nel complesso dei Giordani. Tuttavia, proprio le indagini archeologiche compiute in quest’ ultima area cimiteriale hanno portato alla luce frammenti di una lastra marmorea, risalente al pontificato di Damaso che, parlando di un martire (poi identificato grazie ad altri ritrovamenti come Alessandro) lo indica come uno di sette fratelli. Sembrerebbe pertanto che già questo pontefice, morto nel 384 (11 dicembre) fosse al corrente dell’uccisione di un gruppo familiare di giovani, avvenuta molto probabilmente in una delle prime persecuzioni, i cui particolari, sfumati nel tempo, furono poi sviluppati nel testo della passio che si ispirò al racconto maccabaico.
Anche alcune fonti iconografiche che ritraggono i sette martiri in compagnia della loro madre, rintracciate in un antico oratorio presso il foro di Traiano e nella catacomba di Massimo testimoniano la precoce devozione per questi santi. Dunque, se appare storicamente provata l’esistenza di un martire romano di nome Silvano, più controversa si presenta invece la storia delle sue reliquie, una parte delle quali è appunto venerata a Romagnano.
Sempre nella “Depositio Martirum” viene riportato che il corpo di Silvano, deposto con quello della madre nel cimitero di Massimo sulla via Salaria, fu trafugato dai novazianisti, seguaci del prete Novaziano che contestavano alla Chiesa il diritto di assolvere da colpe gravi e diedero vita ad una comunità autonoma esistente fino all’inizio del V secolo. Non si conosce il motivo di questo furto cui, molto probabilmente, dovette porre rimedio papa Innocenzo I (401 – 417) che confiscò alla setta diversi beni, riportando le reliquie alla loro sede originaria.
Nel complesso di Massimo, infatti, è stata rinvenuta un’iscrizione, posteriore al 390, che lascerebbe supporre la presenza dei resti sia di Felicita sia di Silvano. Il ritorno delle spoglie nel primitivo cimitero risulta confermato anche dal fatto che il successore di Innocenzo, Bonifacio I (418-422), compì dei restauri al sepolcro del martire Silvano, che era ancora lì venerato al tempo di papa Adriano I (772-795), autore di ingenti lavori di manutenzione (come ricordato nella sua biografia contenuta nel “Liber Pontificalis”).
Con il trasferimento delle reliquie dei martiri dalle catacombe alle basiliche urbane, quelle di Felicita e di Silvano vennero collocate da papa Leone III (795-816) nella chiesa di Santa Susanna, da lui fatta quasi totalmente riedificare nel 796. Nella cripta di questa chiesa, purtroppo chiusa per restauri da molti anni, i resti dei due santi ancora riposerebbero all’interno di un altare. Parte di queste reliquie sono però venerate da secoli in quella che era l’antica chiesa abbaziale di Romagnano che, già dedicata a Santa Croce, assunse poi il titolo del santo. La fondazione di questo monastero benedettino, nei primi anni dell’XI secolo, viene attribuita al conte Bosone della famiglia Arduinica – fratello di Guido da cui si originò la famiglia dei Marchesi di Romagnano – a memoria del figlio prematuramente scomparso.
Il primo documento che menziona la presenza delle reliquie di San Silvano risale al 1040 ed è costituito da una donazione che Odolrico, figlio di Guido – dunque nipote di Bosone – e sua moglie Julita compiono in favore della fondazione monastica, a cui assegnano alcuni poderi di loro proprietà siti nei pressi del paese.
Il testo ricorda che nel monastero è conservato il corpo di Silvano e la sua presenza causa il cambiamento del nome stesso dell’intera fondazione, che da quel momento è conosciuta come Abbatia Sancti Silani. La tradizione attribuisce allo stesso Bosone la traslazione dei sacri resti, per nobilitare e qualificare il nuovo cenobio, tuttavia non esistono sfortunatamente documenti che provino o smentiscano questa ipotesi, verosimile se collocata all’interno dell’importanza che le reliquie avevano nella mentalità medievale. In nessuna fonte agiografica antica si parla di un trasferimento dei resti di Silvano a Romagnano, dove sarebbero giunti in un anno imprecisato tra il 1008, se si accetta tale data come fondazione del monastero ed il 1040, quando il complesso porta già il nome del santo. Non è inoltre chiaro se Bosone abbia recuperato le reliquie a Roma oppure a Benevento, dove sarebbero state portate dal re longobardo Desiderio, stando ad una versione della già citata passio, redatta probabilmente in ambito campano per giustificare il culto di alcune reliquie trasportate dall’Urbe.
Durante tutto il medioevo e fino alla fine del Seicento, nel corso delle varie vicende che interessarono l’abbazia, non venne meno la memoria della presenza del corpo del martire all’interno dell’edificio, che riposava sotto l’altare maggiore, come testimoniano le note della visita pastorale di Carlo Bascapè.
Le indicazioni che il vescovo fornisce sono molto importanti, in quanto ricordano sia l’esistenza del cenotafio che monumentalizzava la sepoltura di Silvano, sia la presenza delle pitture che lo decoravano, in cui era raccontata la storia del trasporto a Romagnano dei suoi resti.
Nel corso del XVII secolo, molti paesi della nostra diocesi avevano ottenuto reliquie romane che, esposte in ricche urne, erano diventate oggetto di devozione tra il popolo, come avvenuto anche a Romagnano, con l’arrivo del corposanto di Eusebio. Si avvertì allora la necessità di procedere alla riscoperta dei resti di Silvano che la comunità poteva vantarsi di possedere già da secoli. L’occasione della ricerca venne fornita dal cambiamento della mensa dell’altare maggiore alla fine di novembre del 1770.
Iniziato lo scavo, dopo essere stata rimossa l’antica mensa, venne rinvenuto un grande sarcofago di marmo, aperto solo il 3 gennaio 1771, alla presenza del vescovo Bertone. Dentro: una cassa lignea conteneva un cranio e molte ossa integre, con altre ridotte in frammenti, che furono riconosciute come appartenenti al santo patrono.
Le riscoperte reliquie di Silvano portate alla luce divennero subito motivo di attenzione da parte della comunità che commissionò l’urna per contenerle che, ad un secolo di distanza, venne sostituita da un’altra, opera dello scultore Longhetti di Varallo. In questa occasione, le ossa del santo vennero composte in una figura di cera da don Giulio Guglielmetti prevosto di Intra, come ricorda anche un cartiglio posto nell’urna stessa. Lo scorso maggio, questo corpo in ceroplastica è stato oggetto di una ricognizione scientifica, realizzata dai tecnici del laboratorio Alcor, sotto la direzione del dottor Gianni Brugo che, con la tecnica della radiografia digitale, ha permesso di verificare quantità e, in parte, natura delle ossa presenti al suo interno. Per una più consona conservazione delle spoglie di San Silvano, s’iniziò a pensare alla realizzazione di uno scurolo. Il progetto, eseguito dall’architetto Crippa di Genova, fu condotto a termine e inaugurato solamente nel 1925 e costituisce pertanto l’ultimo esempio di tali tipologie costruttive così numerose nell’ambito della diocesi di Novara. Dal Settecento, in seguito al recupero dei sacri resti, venne introdotto l’uso dei solenni trasporti a scadenza periodica, prima centenaria poi giubilare. Nel 1772, in occasione della prima sistemazione delle reliquie, nel 1871 a cento anni, nel 1921 festa cinquantenaria, nel 1925 per la realizzazione del nuovo scurolo e, da allora, ogni venticinque anni: nel 1950, nel 1975, nel 2000 e in questo 2025.
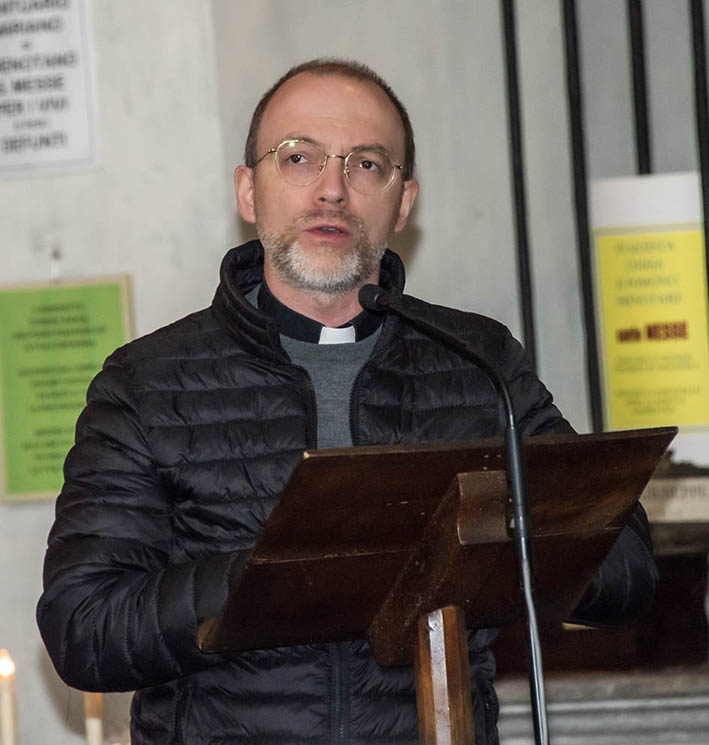
Don Damiano Pomi, docente della Pontificia Università Gregoriana