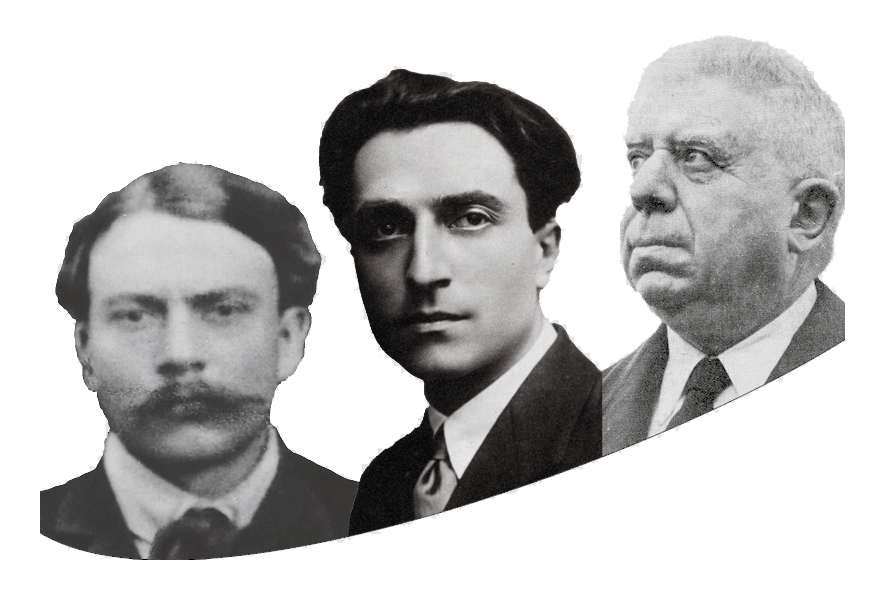«Non dubito, che a quest’ora sarete preparati a ricevere con rassegnazione la cattiva nuova. Il caso amaro è avvenuto stanotte alla una e mezza. Preghiamo per lui, che è quello che ci ha tanto raccomandato. Piaccia al Signore, che da sì grande sciagura ricaviamo quel bene, che egli desidera». Così, la mattina del 1° luglio 1855, scrive da Stresa don Paolo Orsi, annunciando a Giuseppe e Adelaide, fratello e cognata di don Antonio, la sopraggiunta morte di quest’ultimo.
I dolori hanno colpito Rosmini in seguito all’avvelenamento patito nel settembre dell’anno prima a Rovereto. Era stato ad una cena da conoscenti e si era accorto, mentre la sorbiva, che la sua minestra era stata avvelenata. Per giorni era stato allettato, riprendendosi a fatica, rientrando a Stresa solo in ottobre. Nei mesi seguenti ha resistito come ha potuto: nella quiete della Casa Bolongaro, sul lungolago, ha ricevuto confratelli e amici, ha risposto alle lettere, ha cercato persino di completare la Ontologia, un capitolo di quella imponente Teosofia che, una volta ultimata, dovrebbe coronare il sistema filosofico da lui inaugurato nel 1830 col Nuovo Saggio sull’origine delle idee.
Adesso, nel gennaio 1855, don Antonio deve mettersi a letto. «È già il quarto mese che sono ammalato d’incomodi intestinali e passo la mia vita oziando tra il letto ed il lettuccio», scherza con Gustavo Cavour ad aprile. In certi giorni si alza e lavora, in altri è senza forze; le notti sono agitate, le digestioni difficili, il ventre gonfio. Gli occasionali salassi che gli praticano i medici – ne ha ben quattro a prodigarsi, e tra i migliori! – causano solo miglioramenti temporanei. «Speriamo che colla buona cura e col raddolcirsi del tempo presto potrà ritrovarsi in istato di buona salute», auspica il segretario don Carlo Gilardi. Anche il malato stesso si culla nella speranza: con l’arrivo della bella stagione si rimetterà e potrà andare finalmente alle terme di Recoaro, come fa da quando era giovane.
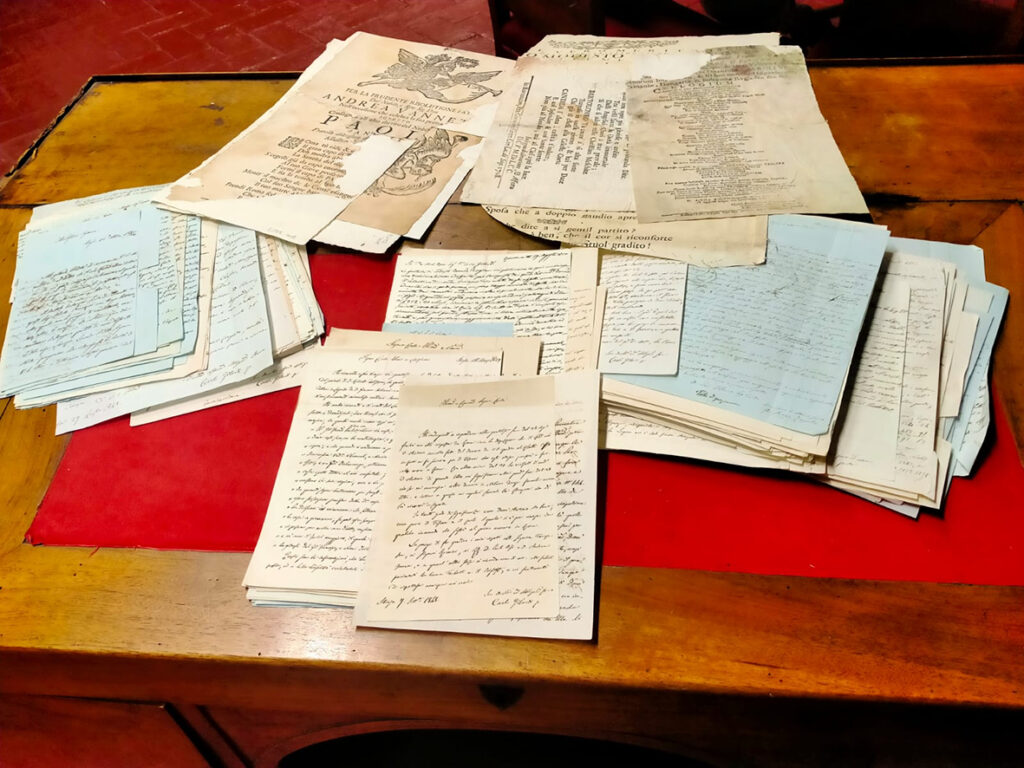
Invece, a fine maggio, arriva il ferale verdetto: «umanamente i medici non danno alcuna speranza», comunica allarmato don Francesco Paoli a Giuseppe e Adelaide. Un po’ di colpa, in fondo, ce l’ha anche Rosmini: non voleva sprecare un minuzzolo di tempo e tutto quel riposo che i medici gli avevano prescritto gli sembrava inutile. Quando poteva, cercava di lavorare. «Non ha per sé tutti quei riguardi che noi desidereremmo e gli veniamo spesso ripetendo», borbottava Gilardi. Ma ora, anch’egli non si illude più. Perciò chiede che da Rovereto venga l’antico amico don Paolo, per stare con lui fino alla fine.
Membro stimato del clero e della società di Rovereto, dove è da decenni professore e direttore del prestigioso liceo, don Paolo è di casa tra i Rosmini fin dai tempi di Pier Modesto e Giovanna, i genitori di don Antonio. Ne ha seguito da vicino la crescita intellettuale e spirituale, insieme al proprio fratello maggiore, don Pietro, morto già da alcuni anni, che di Antonio è stato maestro di filosofia e a cui, nel 1830, Rosmini ha dedicato il suo Nuovo Saggio.
Così don Paolo corre a Stresa. Da quel momento, giorno per giorno, tiene informata sui progressi della salute di Antonio la famiglia Rosmini, che a sua volta gira le lettere agli amici roveretani. Annota puntualmente le tante visite che giungono all’illustre malato: il podestà di Rovereto Cesare Malfatti, Stefano Stampa, Gustavo Cavour, Pier Alessandro Paravia e molti altri, ecclesiastici e laici. Vengono per confortare il morente – Pestalozza piange a dirotto! – e invece è il morente a confortare loro, animandoli alla fede in Dio: «Se sente qualche parola di compassione, dice: Questi patimenti sono un nulla a paragone di ciò che ha patito Gesù Cristo per noi», riporta Orsi edificato.
Arriva Ruggero Bonghi, che eternerà nelle sue Stresiane i colloqui tra Rosmini e Manzoni di cui è stato testimone: «Io sono fra due mondi, il mondo della vanità e il mondo della verità. Fra non molto io mi presenterò al tribunale di Dio. Tutta la nostra speranza dunque si fonda in Gesù Cristo, e nell’essere noi uniti con lui, partecipi della sua divinità mediante il timore filiale e la osservanza de’ suoi comandamenti. Sia dunque la nostra gloria questa di essere cristiani», gli dice il Nostro.
Ecco i maestri rosminiani di Intra, venuti a congedarsi dal loro Fondatore: «Miei cari figli, tutto passa e svanisce. Ora è il tempo del raccolto: il contadino che ha sudato e faticato si conforta alla fine per la messe che raccoglie: così è per chi serve Dio e lavora per Lui. Non potreste farmi cosa più grata, né più consolante, di voler sempre meglio attendere alla vostra vocazione, mediante l’osservanza delle sante Regole. Vivete non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Io non vi dimenticherò mai!» assicura loro.
Il dottor Pogliaghi, da Milano, gli annuncia di aver portato con sé la miglior medicina: «Come? È già venuto Manzoni? E perché l’avete fatto aspettare? Conducetelo subito!» esclama gioioso il malato, quasi rinato. «La sua presenza tra noi è troppo necessaria!», gli dice l’autore dei Promessi Sposi, pregando Dio di conservargli la salute. «Nessuno è necessario a Dio… Le opere che ha incominciato, le compirà con i tanti mezzi che ha e che noi non conosciamo», risponde il filosofo. E gli consegna le famose parole: «adorare, tacere, godere».
Ma più che i conforti umani, Rosmini anela a quelli divini. Quando gli portano il viatico, confratelli, amici e mezza Stresa «si accalcano per entrare quanti più possono nella stanza dell’infermo, bramosi di rimirare un’ultima volta le sembianze dell’uomo che vedono in tanto ossequio del mondo, e che da alcuni anni si gloriano di avere tra loro». Egli, rizzatosi sul letto, recita a chiara voce e posata il Confiteor e la professione di fede: vuole dare – osserva Orsi – una «nuova e solenne testimonianza al mondo del fermo suo attaccamento a quella religione, che cogli scritti, colla voce e colle opere ha sempre professato».
Al momento dell’estrema unzione, «chiede a tutti perdono dei difetti commessi, dichiara di averli sempre amati come figli, li esorta all’orazione, alla mortificazione… La scena è commoventissima: molti piangono a calde lacrime, tutti hanno il dolore e la tenerezza dipinta sul volto». Siamo ormai agli sgoccioli. Il 29 giugno riceve la benedizione del vescovo di Novara mons. Giacomo Filippo Gentile e, il 30, quella del vescovo di Ivrea Luigi Moreno, che lo ringrazia per l’immenso bene che ha fatto a lui, al suo clero, alla sua diocesi, al Piemonte e alla Chiesa intera con la sua santità di vita e con i suoi scritti, grazie ai quali ha impedito che sia approvata la legge sul divorzio. «Si ricordi di noi quando sarà in Paradiso, e preghi per me, per la Chiesa, per tutto il Piemonte!», gli chiede il prelato. «Lo farò, lo farò!», assicura il malato, dettagliando le parole nello sforzo.
«È una vera edificazione vederlo patire con tanta rassegnazione; pare, che propriamente si consoli a patire. Se sente qualche parola di compassione, dice: questi sono un nulla a paragone di ciò che ha patito Gesù per noi!», registra Orsi, mentre Rosmini non riesce più a ingerire o trattenere il cibo. Perde i sensi, cade in agonia, comincia ad agitarsi. Alle 1,30 del 1° luglio si acquieta, le membra si rilassano, il viso si distende. Un attimo, e non è più. «Ha fatto una morte da santo, come santa fu la sua vita», commenta piangendo Orsi.
La salma è vegliata per due giorni, poi «una turba di clero, di ammiratori, di popolo» lo accompagna nella chiesa parrocchiale per i funerali. Da lì, il corteo sale mesto verso quella del Crocifisso, fatta costruire sul colle di Stresa da Rosmini stesso dieci anni prima, dove cala nel sepolcro. «Morì – dice un testimone – con la stessa semplicità con cui era vissuto: uomo davvero straordinario nella sua stessa ordinarietà».

Padre Ludovico Maria Gadaleta