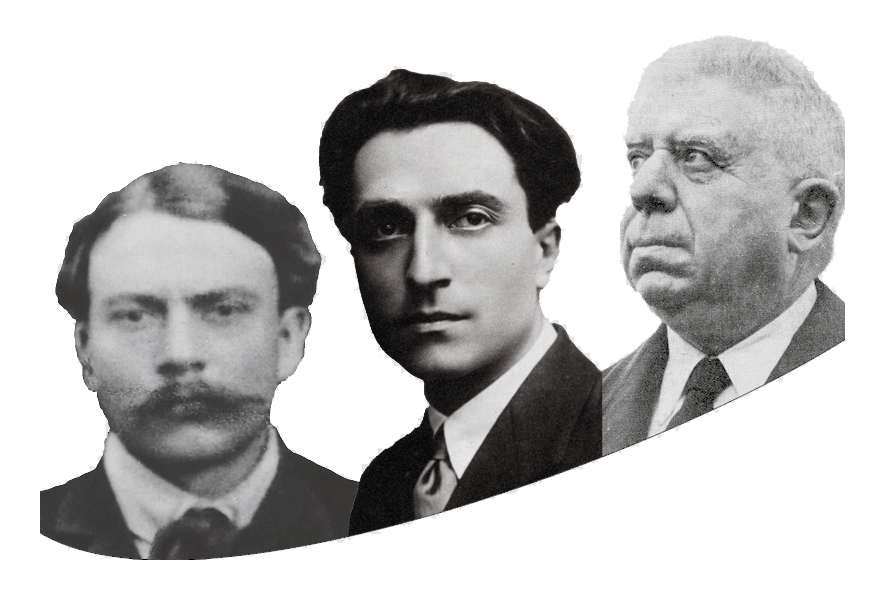«Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato; prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa» (Gn 28,10-12). Il grande patriarca, padre dei dodici fratelli da cui nasce il popolo di Israele, parte per prendere moglie tra le figlie degli Aramei. Sul cammino ha un sogno. Vede una scala che dalla terra raggiunge il cielo e che dal cielo scende sulla terra. Su di essa salgono e scendono gli angeli di Dio.
Tali figure nella Scrittura sacra sono inviati, rappresentanti, interpreti. Messaggeri quando scendono da Dio verso gli uomini, rappresentanti quando mediano tra Dio e l’uomo, interpreti quando ascoltano la voce di Dio e ne fanno eco per i loro destinatari. Questa potente visione s’attaglia perfettamente per trovare il fil rouge del volume di bella fattura, pubblicato da Solferino, col titolo Lo spirito del Novecento, per la curatela di E. Bianchi e M. Vergottini.
Sono 46 profili di giganti del XX secolo, che hanno illuminato la scena del secolo breve, tremendo e fascinoso. Un secolo costellato da due guerre mondali, polarizzato da ideologie contrapposte, dominato da figure tenebrose, attraversato da cesure esaltanti come il ’68 e l’’89, contrappuntato da Pio XI e XII, Giovanni XXIII e Paolo VI, da Giovanni Paolo I e II e, infine, coronato dal sogno europeo di chi voleva rendere presente l’humanitas greco-romana e cristiana.
Immaginiamo questi profili come angeli che salgono e scendono sulla Scala di Giacobbe: taluni sono inviati e messaggeri; altri sono rappresentanti della tragedia umana davanti a Dio e della levità della grazia divina per gli uomini; altri, infine, sono interpreti del secolo che ha smarrito la verità e la cerca dentro una narrazione interminabile, per venire a capo dell’assoluto nella storia e dell’eterno nel tempo.
La configurazione dell’opera presenta come sette gradi dell’agire e della conoscenza che sale verso Dio e che da Dio, talvolta solo dal divino, raggiunge gli uomini con la sua condiscendenza.
I protagonisti vi salgono e scendono, talvolta enfatizzando la spinta ascendente, talaltra facilitando la corrente discendente. L’opera ha uno scopo soltanto. Non disperdere la memoria di un secolo stupendo e drammatico. Partiamo dal basso per ascendere, non dimenticando che ogni passo che sale contiene un gradino che discende. Per questo ogni ascesa è contrassegnata da un verbo, e la discesa da una scena dello spirito del Novecento.
Danzare la vita
Il primo grado della conoscenza dell’uomo, del mondo e di Dio è l’agire. La via per arrivare in alto ha come prima mossa l’incontro con figure straordinarie che hanno incarnato la lotta per la dignità e la giustizia in un secolo spesso segnato dalla disumanità. Da Nelson Mandela a Madre Teresa di Calcutta, da Martin Luther King a Marianella García Villas, questi protagonisti hanno trasformato la fede in un movimento vitale, capace di scendere nelle piazze, nelle favelas, nei campi di battaglia della storia, per danzare con i più poveri, gli oppressi, i dimenticati.
Sono angeli che ricordano che la vita può essere vissuta come un atto di resistenza e resa, resistenza al male, resa davanti al mistero dell’amore ferito e riconciliato.
Sognare la Chiesa
Il secondo grado schiera donne e uomini che nel XX secolo hanno creduto nella possibilità di una Chiesa più aperta, dialogante, vicina ai bisogni del mondo. Hélder Câmara, Roger Schutz, Madeleine Delbrêl: ognuno di loro ha contribuito a immaginare una Chiesa che respira con i polmoni della profezia e della comunione, che non è arroccata su sé stessa ma rivolta verso l’altro e il mondo. Sono angeli interpreti che con una mano stringono la mano agli uomini del loro tempo e col cuore battono all’unisono con Dio.
Rendere ragione della fede
Il terzo grado ci introduce nella radura dei grandi esponenti della teologia del Novecento cristiano. Teologi cattolici come Yves Congar, Edward Schillebeeckx e Gustavo Gutiérrez, evangelici come Dietrich Bonhoeffer o Elisabeth e Jürgen Moltmann, sono angeli rappresentanti che hanno esplorato il mistero della fede con strumenti nuovi, dialogando con la scienza, la filosofia, la letteratura. Hanno cercato un nuovo linguaggio per coniugare Vangelo e cultura, perché il primo abbia il sapore del tempo e la seconda sia lievitata dalla radicale novità di Cristo.
Scrutare le Scritture
Il grado successivo fa addentrare nel lavorìo di chi ha affrontato la Scrittura sacra mettendo in luce il fatto che essa è Parola di Dio in linguaggio umano, legge e cammino, profezia e storia, sapienza e conoscenza. Biblisti del calibro di Joachim Jeremias, Luis Alonso Schökel o Paul Beauchamp hanno aperto nuove strade nella comprensione del Libro sacro, facendoci ascoltare la Parola che scende dall’alto dentro i racconti umani che salgono dal basso.
Essere nella verità
Il quinto grado esplora il pensiero di alcune delle menti più lucide del secolo scorso, come Simone Weil, Etty Hillesum, Emmanuel Mounier e Paul Ricoeur. Sono filosofi, mistici, testimoni che hanno cercato la verità non come possesso, ma come un cammino, spesso doloroso e scomodo. Al centro della scala che sale a Dio e che scende verso gli uomini, il loro pensiero non ha dato risposte facili, ma ha prodotto una ricerca incessante, che mette in dialogo la ragione e il mistero.
Indagare l’humanum
Sul sesto grado: una teoria di figure che hanno sondato l’enigma dell’umano, esplorandone fragilità, risorse e tensioni. Paulo Freire con lo sguardo acuto dell’educatore dei poveri, Françoise Dolto con la delicatezza di chi sa ascoltare l’infanzia ferita, Antoine Vergote nel dialogo tra fede e psiche, Hubert Jedin nell’indagine accurata della memoria ecclesiale, Jean Leclercq nel silenzio sapienziale del monaco studioso, Giovanni Pozzi nella parola che si fa bellezza e rivelazione. Questi sono gli interpreti che hanno percorso l’ascesa della tormentata conoscenza umana e la discesa della lacerata sapienza divina nel e per il Novecento.
Svelare la bellezza
L’ultimo grado porta sulla soglia del Paradiso, quando appaiono artisti e scrittori che hanno saputo raccontare il sacro attraverso il linguaggio dell’arte. Flannery O’Connor, Thomas Merton, Andy Warhol, Andrej Tarkovskij: artisti che interpretano il Novecento con un’estetica tormentata ed esaltante, in cui si illuminano anche le pieghe più oscure della condizione umana. La loro opera ricorda che la bellezza è il riflesso dello splendore di Dio nel mondo. È il sommo della Scala di Giacobbe che illumina l’umana salita perché segue la traccia della divina discesa agli inferi.
Il testo della Genesi commenta così il sogno di Giacobbe: «Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: “Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo”. Ebbe timore e disse: “Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo”» (Gn 28,16-17). Scala verso l’alto, porta del cielo è stato il Novecento. Non possiamo disperderne la memoria!

Mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara