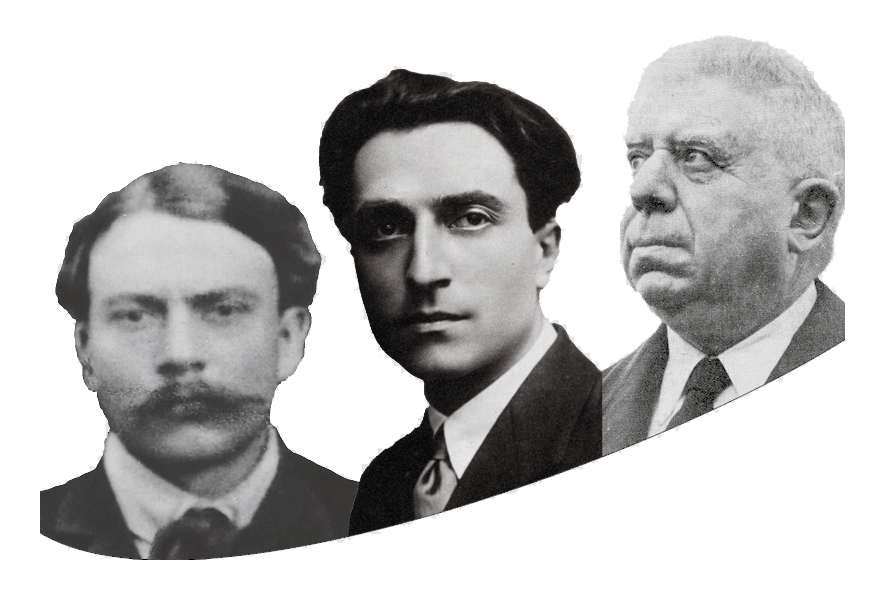L’undicesima e ultima puntata della nostra rubrica dedicata al Giubileo della Speranza. Un piccolo approfondimento e una breve meditazione sui temi che l’Anno Santo mette al centro del percorso della comunità ecclesiale, sulle sfide per tutta la società civile e su come ogni fedele può essere interrogato dalla “Speranza che non delude”.
L’ultima dimensione del giubileo è la pace: opus iustitiae pax, «la pace è l’opera della giustizia» (Is 32,17), «giustizia e pace si baceranno» (Sal 85,11), «vi do la mia pace, non come la dà il mondo» (Gv 14,27). Queste citazioni bibliche affermano che la pace è un dono escatologico che, quando accolto dall’alto, rende capace gli uomini di trasformare le forme della loro convivenza e di generare rapporti giusti. Tale duplice valenza della pace, come dono di Dio e come modo della convivenza umana, è immersa nella vicenda storica e presenta un’esperienza della pace più precaria e contrastata.
Modelli della pace
Sono quattro i modelli di pace che esprimono i due aspetti fondamentali della pace, quello teologico-salvifico e quello storico-civile. Essi formano i grandi filoni che confluiscono nella cultura occidentale.
La pace come intervallo. Nel mondo greco, la pace (eiréne) non indica un rapporto tra gli umani, né un modo di agire, né un rapporto giuridico. La pace è vissuta come un “intervallo”, è la situazione di sospensione del pólemos, della guerra, è la quiete prima e dopo la tempesta, lo stato sereno di vita che fa da intervallo in mezzo all’infuriare delle battaglie.
La pace come ordine imposto. La pace nel mondo romano, la pax romana, rimane ancora un’interruzione della guerra, ma adesso assume una valenza nuova, tende ad essere non solo l’intervallo della lotta e della violenza, ma un programma politico, un ordine stabile imposto con la violenza, con la ragione del conquistatore che detta le regole della convivenza.
La pace come forma di vita. Nell’Antico Testamento shalom è un termine molto comune nella vita quotidiana: esso indica benessere integrale, che abbraccia tutto l’uomo, il suo corpo, l’anima, la comunità, il gruppo, l’ambiente naturale e tutte le relazioni in cui l’uomo vive. Il termine deriva da una radice che significa “avere a sufficienza” e quindi indica una forma di vita in cui tutti “hanno a sufficienza”, prima di tutto nel campo dei beni, ma poi in tutte le relazioni, umane, sociali e cosmiche.
La pace come dono promesso. L’ultimo modello della pace raccoglie questa eredità escatologica, ed è la pace come dono promesso. Il Nuovo Testamento riprende il termine greco eiréne, che però riempie del significato ebraico dello shalom e lo radicalizza come dono di Dio e del Risorto. Il suo saluto pasquale diventa promessa del dono escatologico della pienezza di vita con Dio e dell’integrità della vita dell’uomo sofferente sotto il peso del male. «Va in pace, e sii guarita dal tuo male», dice Gesù alla donna risanata (Mc 5,34). La pace è la liberazione dal male e il dono per vivere. In questo senso è il dono che corona il Giubileo.
Piste di ricerca
1.La coscienza della pace. In presenza di una guerra nel cuore dell’Europa, è decisivo nutrire una coscienza della pace, che si alimenti al senso evangelico del dono divino della pace (shalom) che va accolto nella comunione con Dio e nel riconoscimento della fratellanza umana. Questi gli elementi qualificanti: l’amicizia civile, la giustizia sociale, la distribuzione equa delle risorse, l’ospitalità per le immigrazioni interne ed esterne, la cura della natura, lo scambio tra i popoli, la conoscenza delle culture, la condivisione dei saperi, la reciprocità delle conoscenze sanitarie e tecnologiche, l’interconnessione digitale, una globalizzazione rispettosa delle identità locali e della democrazia tra le nazioni.
2. La cultura della pace. Il rapporto tra la pace come dono escatologico e la pace come responsabilità personale, familiare e socio-politica dischiude davanti a noi il grande compito di una pedagogia della pace, che guarisca dalle malattie della pace: l’isteria di guerra, la menzogna come strumento di offesa, la “spionite”, la criminalizzazione del popolo nemico, la radicalizzazione del conflitto, la deformazione della realtà, l’illusione di poter controllare la violenza e la forza.
3. La pragmatica della pace. Strettamente intrecciata con la formazione alla pace, occorre favorire un’azione concertata per la pace. I temi del cessate il fuoco, dei negoziati, e in particolare del ruolo specifico dell’Europa sono diventati temi tabù. Bisogna indicare le azioni di una pragmatica della pace, favorendo gesti di accoglienza degli esuli, corridoi per le risorse e le merci (cf i cereali), altre forme di intervento e di aiuto per il ripristino di funzioni vitali per le popolazioni. Una diplomazia della pace dovrebbe essere in grado di suggerire azioni e contatti, canali di intermediazione e personale esperto, per mettere in campo le azioni della pace (cf testo).
4. I luoghi e i responsabili della pace. Sono ancora due i temi da sostenere. Il primo riguarda una ecologia della pace: essa ha bisogno di una casa (oikos) dove si costruiscano i legami tra le persone, le famiglie e le nazioni. Il secondo concerne i responsabili della pace, cioè i soggetti che, nel quadro di una pedagogia e una pragmatica della pace, scendano in campo come operatori di pace (cf testo).

Mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara
L’articolo integrale con tutti gli articoli dal territorio della Diocesi di Novara si potranno trovare sul nostro settimanale in edicola a partire da venerdì 20 giugno. Il settimanale si può leggere abbonandosi o acquistando il numero che interessa cliccando direttamente qui.
Tutti i testi della Rubrica sul Giubileo sono raccolti nella pagina dedicata.