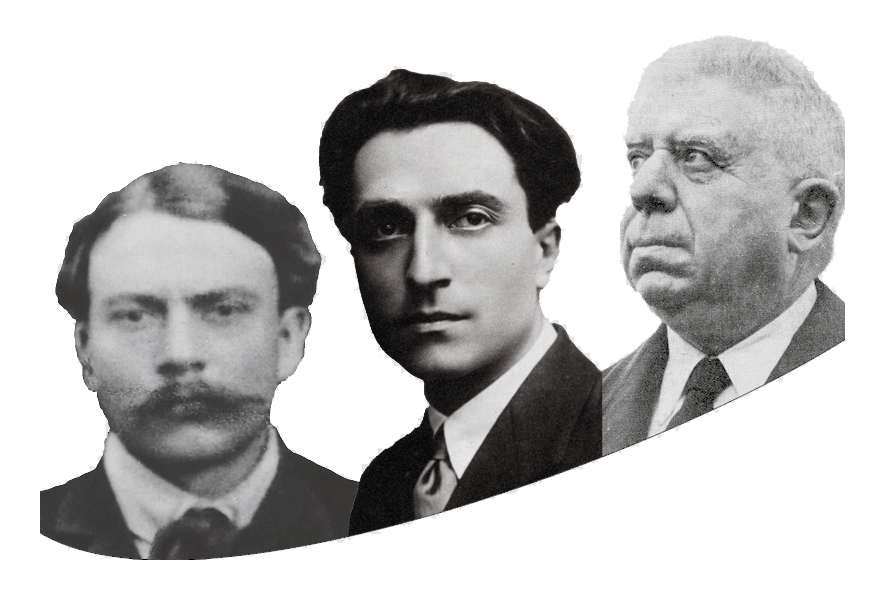L’ottava puntata della nostra rubrica dedicata al Giubileo della Speranza. Un piccolo approfondimento e una breve meditazione sui temi che l’Anno Santo mette al centro del percorso della comunità ecclesiale, sulle sfide per tutta la società civile e su come ogni fedele può̀ essere interrogato dalla “Speranza che non delude”.
Arrivati sin qui, dobbiamo ora raccogliere il “sugo della storia”. Il primo tratto riguarda la relazione tra il Giubileo e la conversione della persona.
Riconciliazione e indulgenza
La fede cristiana parla di colpa, di pena (temporale ed eterna), di perdono e di misericordia per descrivere sia la rottura del rapporto con Dio e con gli uomini, sia il ricupero faticoso della relazione ferita attraverso un cammino di penitenza e riconciliazione. Per questo il linguaggio del peccato e della penitenza è strettamente collegato con il cammino e il gesto della riconciliazione. In tale contesto, come si è visto, è nato il tema dell’indulgenza, come modo per “commutare” o “redimere” la penitenza sacramentale con gesti di fede e di carità che permutavano o abbreviavano la penitenza imposta dalla chiesa. Di qui anche il linguaggio e le modalità del tema: si parla di tesoro della chiesa, di lucrare e acquistare l’indulgenza; essa può essere “parziale” a sconto di una parte della penitenza o “plenaria” come condono di tutta la pena temporale.
Il linguaggio tradizionale, tuttavia, anche per gli abusi che vi sono stati e che hanno causato la reazione violenta della Riforma protestante, non riesce ad indicare a sufficienza il modo con cui la grazia del perdono trasforma l’agire della libertà: con il corpo e gli altri, nel mondo e nella chiesa, e di fronte a Dio. Spesso tale linguaggio è stato ripetuto e proposto con una mentalità quantitativa, quasi commerciale o mercantile, parlando di retribuzione, di scambio e contrassegnando in maniera materiale anche i modi di dire e di fare. L’indulgenza s’inseriva nel cammino penitenziale del soggetto e nell’accompagnamento della chiesa. Uscire dal peccato non poteva essere un fatto magico e automatico, ma la grazia del perdono della colpa, una volta confessata, esigeva un itinerario faticoso (il laboriosus baptismus dei Padri della Chiesa). Durante questo tempo, il penitente non poteva essere lasciato solo, ma era accompagnato dalla preghiera e dall’annuncio della parola, e soprattutto dalla comunione fraterna della comunità.
L’indulgenza nel cammino di conversione
Occorre rileggere il linguaggio della tradizione con due attenzioni: la prima mette all’inizio, al centro e alla fine del cammino di conversione la grazia di Dio, e nel Giubileo l’“anno di grazia” del Signore; la seconda mostra come il dono di Dio, proprio perché è una “grazia a caro prezzo”, non solo esige, ma rende possibile la trasformazione del cuore e della vita. Dio sa quanto è faticosa la trasformazione dell’agire umano! E l’uomo sperimenta che è persuasivo per lui elaborare le proprie ferite e debolezze e non solo fasciarle.
Allora occorre dire che all’origine della riconciliazione sta il Gesù Signore, principio e fine della riconciliazione con Dio («Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» 2Cor 5,20), novità di grazia e di vita per l’uomo d’oggi, mediante il dono del suo Spirito. Gesù è la grazia in persona, colui che ci dona di sperare una conversione e una trasformazione radicale della nostra vita.
La chiesa luogo del perdono
Il Risorto ha donato alla chiesa, mediante l’effusione del suo Spirito, di essere la comunità della riconciliazione (Gv 20,19-23; Mt 18,21-22). La riconciliazione con Dio passa attraverso la chiesa luogo e sacramento del perdono. Il perdono che la chiesa accoglie e concede al fratello peccatore, rifluisce come dono di grazia su sé stessa, e diventa forza di rinnovamento che rende la chiesa sua sposa, senza macchia né ruga.
La “comunione dei santi” (communio sanctorum, delle cose sante e dei santi con Maria) è allora la sorgente zampillante a cui può alimentarsi continuamente ogni cammino di conversione. La chiesa non accompagna solo il perdono, ma ha in carico anche il fratello nel ricuperare la sua libertà scissa, ferita, divisa, egoista. Essa aiuta a guarire le abitudini sbagliate, sedimentate nel corpo, nell’immaginario, nella ripetizione, tra le pieghe della vita, per ricostruire le relazioni distorte, deformate, conflittuali, le solitudini e le ingiustizie, le divisioni e le inimicizie.
Tutto ciò mette in luce un aspetto antropologico fondamentale: l’uomo riceve il perdono non solo ricuperando le intenzioni, le motivazioni deviate della mente e del cuore (la conversione), ma anche plasmando il corpo, le abitudini, il costume, le inclinazioni, le radici dell’agire umano, tutto ciò che precede (le cause) e segue (le conseguenze), ma non è esterno alla libertà. L’uomo dentro l’azione dello Spirito si lascia trasformare non solo nel suo essere e nel suo agire, ma anche nelle condizioni e nelle conseguenze del suo operare, fin nelle fibre profonde dell’esistenza. Qui si colloca l’indulgenza: essa non è un condono che riduce il debito personale, ma è un dono che diventa appello alla nostra libertà perché non si fermi solo sulla giustizia delle opere (mal)fatte, ma si lasci toccare dalla misericordia della grazia divina che ci dice: coraggio, tu sei di più dei tuoi gesti sbagliati e dei tuoi peccati. Puoi cambiare vita! La grande “perdonanza” ne è un richiamo potente ogni 25 anni!

Mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara
L’articolo integrale con tutti gli articoli dal territorio della Diocesi di Novara si potranno trovare sul nostro settimanale in edicola a partire da venerdì 30 maggio. Il settimanale si può leggere abbonandosi o acquistando il numero che interessa cliccando direttamente qui.
Tutti i testi della Rubrica sul Giubileo sono raccolti nella pagina dedicata.