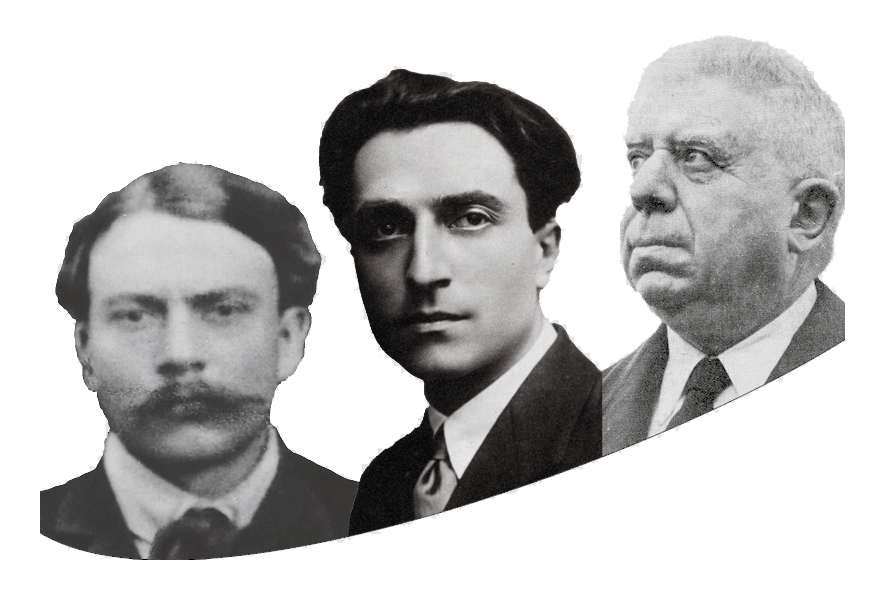La nona puntata della nostra rubrica dedicata al Giubileo della Speranza. Un piccolo approfondi- mento e una breve meditazione sui temi che l’Anno Santo mette al centro del percorso della comunità ecclesiale, sulle sfide per tutta la società civile e su come ogni fedele può essere interrogato dalla “Speranza che non delude”.
La conversione della persona non può avvenire che nella trama delle relazioni familiari ed ecclesiali, sociali e internazionali. Fermiamoci per ora sulle prime due.
Il senso e i gesti della indulgenza
L’uomo non accede al perdono solo nella “parola” e nel “sacramento”, mediante la conversione del suo peccato, ma ha da accoglierlo anche con la “penitenza” (sacramentale e personale). In quest’ottica si può rileggere pure per oggi il valore dell’indulgenza. In un tempo determinato e dentro un cammino ecclesiale, la chiesa chiama se stessa e tutti i credenti ad accogliere il dono sovrabbondante di una grazia singolare: con i gesti e i modi richiesti, il cuore del credente si lascia ricuperare fin nelle fibre più profonde della libertà, nei pensieri, nelle abitudini, nell’immaginario, nelle inclinazioni, per far compiere alla libertà un autentico pellegrinaggio del cuore e del corpo. Il credente fa questo non solo per sé, ma insieme agli altri, in particolare anche per coloro che gli sono stati cari (i defunti) e che lo hanno preceduto nel segno della fede.
Si può cogliere così anche il valore dei gesti della riconciliazione. Accanto ai gesti della penitenza sacramentale e personale (purtroppo oggi diventata evanescente nella vita della chiesa e del cristiano, perché dopo il Concilio di Trento la penitenza è divenuta solo “orale”, ridotta ad alcune preghiere da dire), l’indulgenza richiede anzitutto di essere accolta dentro uno spirito di gratuità e di dedizione.
L’indulgenza è il dono di una grazia sovrabbondante e smisurata che viene solo da Dio nella pasqua del Signore Gesù: in questo senso l’indulgenza non si può acquistare! Essa è radicalmente dono di Dio (indulgenza!) accolto nel grembo della chiesa.
Proprio perché è dono di Dio, essa richiede di permeare tutta la nostra vita, il nostro corpo, le nostre relazioni, gli angoli nascosti della nostra esistenza (in questo senso è “plenaria”). Proprio perché la misericordia di Dio è un dono grande che ci dà forza e coraggio anche dove non speriamo più, l’indulgenza può e dev’essere vissuta con gli altri (in questo senso è “ecclesiale”). Perciò ha bisogno di esprimersi anche con gesti di preghiera, di penitenza, di pellegrinaggio, di carità, di generosità, di servizio, personale e sociale, che esprimono nello spazio e nel tempo la forza trasformante e irradiante della grazia di Dio.
Per questo l’indulgenza accade anche in un “tempo straordinario” (ogni venticinque anni) per dare un volto nuovo al nostro tempo, al lavoro, alla fretta, per ritrovare noi stessi, la famiglia, la comunità, il senso della domenica, della festa, la pace del cuore e la comunione con gli altri. Essa coinvolge anche i nostri fratelli defunti, coloro che sono stati figure importanti nella nostra vita e nella storia della nostra comunità.
Nella famiglia e nella chiesa
La famiglia è il grembo dei rapporti interpersonali che trasmette le esperienze fondamentali della vita. Essa è passata negli ultimi ottant’anni dalla famiglia patriarcale alla famiglia nucleare, composta solo dalla coppia e dai figli, e dalla famiglia monoparentale alla famiglia affettiva, dove conta l’esperienza di benessere in essa possibile. Molte situazioni domestiche oggi sono sofferenti per le relazioni irregolari e plurali, che esigono vigilanza e accoglienza. Il giubileo potrebbe rappresentare un’occasione propizia per la riconciliazione delle situazioni familiari risanando le famiglie dal cuore ferito, aiutando a mettere al centro il bene dei figli, puntando di più sull’educazione che sull’avere e sul benessere, ma soprattutto trasmettendo le esperienze fondanti dell’identità della persona: la vita, la casa, l’affetto, la parola e la fede. Sono i cinque doni che strutturano l’identità personale dei figli, sono messi alla prova nell’adolescenza e vanno personalizzati nella giovinezza, perché i figli diventino adulti e i genitori raggiungano la loro pienezza generativa.
La comunità cristiana è il luogo simbolico in cui si realizza il “noi sociale” dei credenti, non solo come comunità della cura, ma come cura della fraternità, cioè di quel legame che o ci trova uguali o ci rende uguali. Il privilegio del povero non è per sentirci bravi, ma è per dare la possibilità agli ultimi e agli svantaggiati di ogni strato sociale o condizione spirituale di essere liberati, di spezzare le catene, di riavere occhi per vedere, gambe per camminare, cuore per sperare. L’“anno di grazia” del Signore è un anno di liberazione da ogni legame servile, per introdurci nell’unico servizio liberante che crea il “nuovo spazio di esistenza” dei cristiani della risurrezione (J. Ratzinger), quello della comunione fraterna.
Detto in modo semplice: l’Anno Santo non si misura nella quantità delle opere di carità e di solidarietà, ma nel fatto che, attraverso di quelle e soprattutto mediante la conversione delle relazioni interpersonali, avremo fatto crescere il tasso di fraternità nelle comunità cristiane. Alla fine, saremo giudicati sulla carità, ma la carità compiuta è l’amore fraterno! Saremo beati non tanto per quanti poveri avremo aiutato, ma per come avremo fatto sedere i poveri alla mensa della comunione fraterna. Perché la chiesa possa essere segno vivo di fronte al mondo d’oggi, non un arcipelago di individui, ma l’armonia dei legami e la sinfonia dei doni!

Mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara
L’articolo integrale con tutti gli articoli dal territorio della Diocesi di Novara si potranno trovare sul nostro settimanale in edicola a partire da venerdì 6 giugno. Il settimanale si può leggere abbonandosi o acquistando il numero che interessa cliccando direttamente qui.
Tutti i testi della Rubrica sul Giubileo sono raccolti nella pagina dedicata.