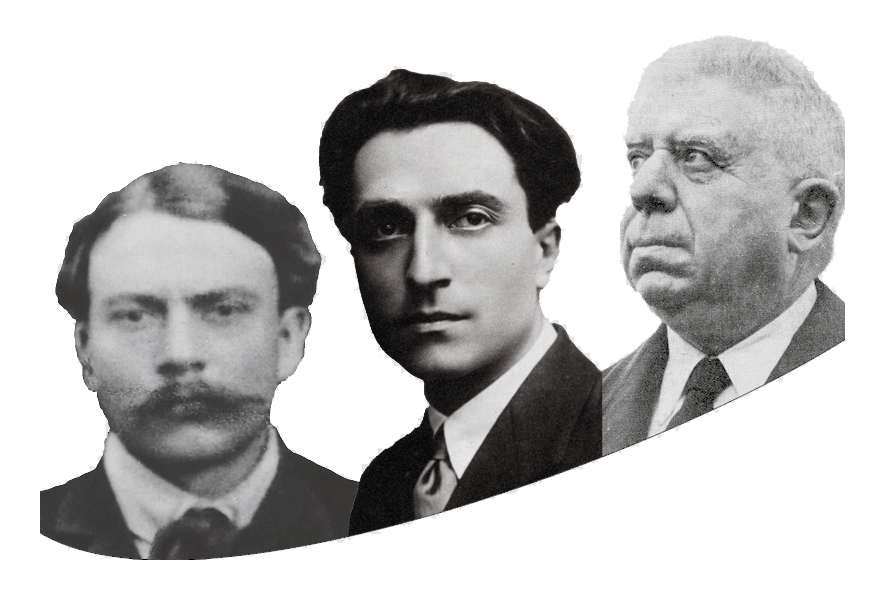La sesta puntata della nostra rubrica dedicata al Giubileo della Speranza. Un piccolo approfondimento e una breve meditazione sui temi che l’Anno Santo mette al centro del percorso della comunità ecclesiale, sulle sfide per tutta la società civile e su come ogni fedele può essere interrogato dalla “Speranza che non delude”.
Dopo la svolta dell’anno Mille, ci avviciniamo alla proclamazione del primo Giubileo con Bonifacio VIII nel 1300.
La penitenza tariffata
La prima importante modifica riguarda la stessa penitenza-soddisfazione. Originariamente la penitenza era costituita da due componenti: le mortificazioni corporali (digiuno, soprattutto) e la durata fissata secondo ben precise «tariffe» stabilite nei libri penitenziali (per questo si parla di «penitenza tariffata»). Per esempio, all’incestuoso o all’abusatore venivano inflitti tre anni di penitenza «cum peregrinatione perenni», il che significava il bando o l’esilio dalla famiglia e dalla patria. Con il passare del tempo, però, questa configurazione della penitenza venne modificata. Il confessore poteva “commutare” sia le mortificazioni corporali sia la durata prevista dai libri penitenziali in una penitenza più accessibile e realista, come le elemosine, le pie fondazioni e i pellegrinaggi, sostitutivi del bando o dell’esilio (di qui il nesso tra indulgenza, pellegrinaggio, che confluiranno nel giubileo). Le “commutazioni” (chiamate anche “redenzioni”) dovevano avere un valore equivalente alla penitenza prevista dai libri penitenziali, ovvero potevano essere più brevi, ma più intense nel sacrificio.
Le prime indulgenze
In seguito, tre passaggi decisivi danno origine al sorgere delle indulgenze.
Primo passaggio: i vescovi e i papi, accordando le intercessioni (dette “assoluzioni”) al di fuori del processo di riconciliazione, cominciarono a rimettere, in parte o totalmente, la penitenza-soddisfazione imposta ai fedeli dal confessore. Con questo si ebbero le prime indulgenze, poiché l’autorità gerarchica concedeva un condono parziale o totale dalla penitenza che faceva seguito all’assoluzione data dal confessore.
Il secondo passaggio: il condono concesso dai vescovi e dai papi non era affatto gratuito, poiché esso veniva compiuto sotto la forma di una “commutazione” della penitenza, mediante un’opera pia da svolgere. Venivano così introdotte due novità. Anzitutto, fu abbandonato il principio di equivalenza; poi, a differenza delle commutazioni, le indulgenze valevano per tutti i fedeli e non richiedevano l’intervento del confessore.
Il terzo passaggio: vi furono i «primi esempi di indulgenza plenaria», quando Alessandro II nel 1063 (in occasione dell’invio contro gli arabi spagnoli delle truppe cristiane) ed Urbano II nel 1095 (in occasione dell’indizione della prima crociata) «accordarono la remissione, non parziale ma totale, della penitenza dovuta per i peccati che i difensori della fede [cavalieri e crociati] avessero confessato». Simili indulgenze furono date in seguito dai papi in occasioni analoghe.
“Tempo gradito a Dio”
La tradizione del giubileo è stata elaborata grazie al contributo di una corrente mistica che riprendeva il filone spirituale ebraico. Il giubileo venne collegato alle crociate verso la Terra Santa, inaugurate da Urbano II nel 1095, in occasione del sinodo di Clermont. In particolare, fu San Bernardo, nel corso della predicazione della seconda crociata (1147-1149) ad assimilare l’indulgenza della crociata ad un giubileo. Per San Bernardo la crociata è il giubileo cristiano, in ragione dell’abbondanza dell’indulgenza offerta: «annus placabilis Domino, annus remissionis, annus utique jubilaeus» (un anno gradito a Dio, un anno di remissione, un anno certamente giubilare). La crociata unisce insieme giubileo e indulgenza.
La corrente mistica giunse all’interpretazione spirituale del giubileo grazie ad un secondo legame, quel-lo stabilito tra giubileo (jubilaeus) e giubilo, ovvero gioia interiore (jubilus). Questo legame si sviluppò negli ambienti monastici: offre una chiara testimonianza del legame jubilaeus-jubilus Riccardo di San Vittore (+ 1173) nella glossa a Lv 25, 8 (nel testo in pagina ndr.).
Un avvenimento accaduto il 7 luglio 1220 è testimone del punto di approdo a cui era giunta l’elaborazione del giubileo cristiano nel sec. XIII. Durante la traslazione dei resti di Tommaso Becket, l’arcivescovo di Canterbury assassinato 50 anni prima (1170), il suo successore Stefano di Langton tenne un sermone (nel testo in pagina ndr.), nel quale si affermava che la venia peccatorum è l’equivalente di «remissione della pena del peccato», espressione usata da Innocenzo III (1198-1216) e dal Lateranense IV (1215). In questo modo venne pienamente realizzato quanto San Bernardo aveva già prospettato in occa-sione della seconda crociata: la fruizione dell’indulgenza plenaria concessa dal papa costituiva il giubileo cristiano.
Si è ormai sulla strada che conduce a quella «pienissima perdonanza» (plenissima venia), concessa da Bonifacio VIII nel 1300.

Mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara
L’articolo integrale con tutti gli articoli dal territorio della Diocesi di Novara si potranno trovare sul nostro settimanale in edicola a partire da venerdì 16 maggio. Il settimanale si può leggere abbonandosi o acquistando il numero che interessa cliccando direttamente qui.
Tutti i testi della Rubrica sul Giubileo sono raccolti nella pagina dedicata.